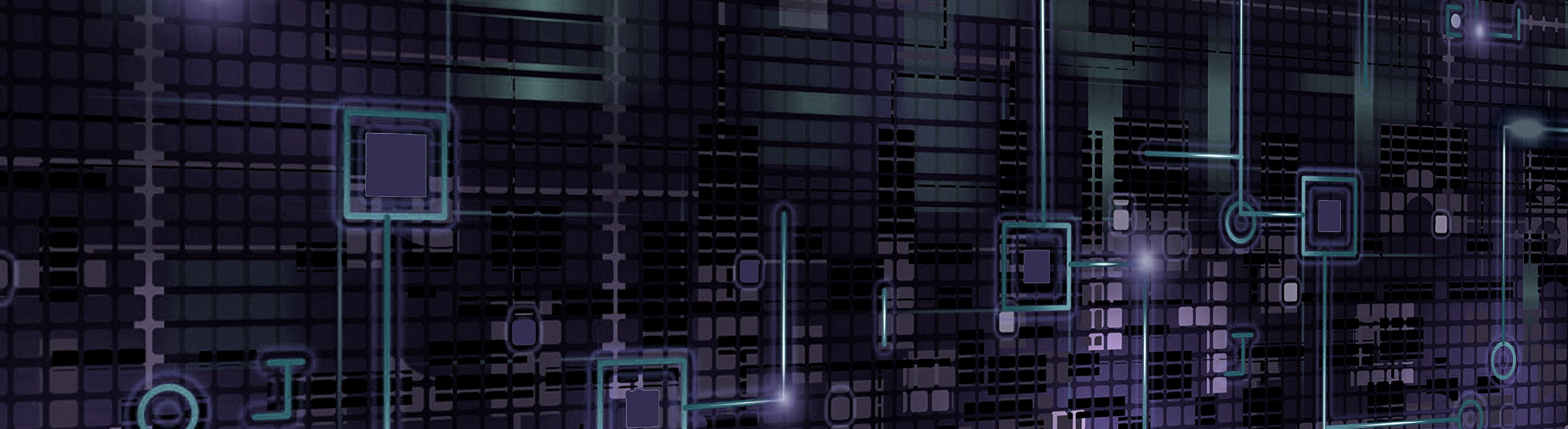Allegra Ianiti, Research Analyst
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci è stato spesso chiesto, in questi giorni, se la Conferenza delle Parti (COP) è ancora uno strumento utile, se ha ancora valore.
La nostra posizione è chiara: nonostante limiti evidenti, le COP restano uno strumento indispensabile. E il motivo è strutturale. Mettere d’accordo 198 Paesi con priorità, livelli di sviluppo e responsabilità storiche profondamente diversi significa, per definizione, avanzare a piccoli passi. Ma nessun altro foro multilaterale permette a governi, imprese e società civile di confrontarsi, definire regole comuni e coordinare la transizione climatica a livello globale.
La prova è nei numeri: rispetto al 2015, le proiezioni sulle temperature globali si sono abbassate, segno che l’architettura multilaterale ha esercitato un’influenza concreta sull’azione climatica, pur rivelandosi ancora insufficiente a colmare il divario che separa il mondo dagli obiettivi concordati.
Dalle promesse all’attuazione
COP30 aveva anticipato un cambio di fase: meno enfasi su nuovi impegni e maggiore concentrazione sull’attuazione, attraverso strumenti regolatori più mirati, investimenti dedicati e mobilitazione del caoitale. La conferenza assumeva inoltre una forte valenza simbolica, celebrando il decennale dell’Accordo di Parigi e riportando il negoziato in Brasile, luogo d’origine dell’UNFCCC nel 1992. L’ambientazione amazzonica orientava naturalmente il dibattito verso natura, foreste, biodiversità e bioeconomia.
Gli esiti finali hanno confermato tale impostazione, con un’attenzione marcata agli strumenti operativi e finanziari: l’impegno a triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035 (Global Mutirão), il rafforzamento dei meccanismi di sostegno ai Paesi vulnerabili e l’avvio della Baku–Belém Climate Finance Roadmap. Rimangono tuttavia assenti, nel testo negoziato, riferimenti vincolanti al phase-out dei combustibili fossili
Con la presentazione dei nuovi NDC, Belém era attesa come verifica della distanza tra impegni e risultati concreti. Il bilancio è misto: avanzamenti tangibili su adattamento e natura; progressi più circoscritti su finanza e mitigazione, ancora lontani dal riorientare la traiettoria globale verso gli 1,5°C.
Quali sono state le priorità dei partecipanti
COP30 è stata costruita attorno a un’idea centrale: l’implementazione. Una dinamica articolata su tre livelli complementari:
- Livello nazionale – Aggiornamento degli NDC e rafforzamento della coerenza tra obiettivi climatici, politiche industriali e strumenti fiscali e regolatori, con crescente attenzione alla credibilità dei meccanismi di attuazione.
- Livello subnazionale – Valorizzazione del ruolo di città e regioni come attori chiave nell’esecuzione delle misure di attuazione, in particolare su edilizia, raffrescamento, trasporti, housing e resilienza locale. Tuttavia, il testo finale non ha attribuito a questo livello un ruolo operativo così incisivo quanto inizialmente prospettato.
- Finanza – Avvio della costruzione di una roadmap credibile tra Baku e Belém sulla finanza climatica, volta a chiarire la ripartizione tra capitale pubblico, privato e concessional.
Sul piano politico, le attese convergevano su una dichiarazione di alto profilo sulla transizione, sostenuta anche dai Paesi BRICS. La dichiarazione è stata effettivamente adottata, ma con un linguaggio più cauto del previsto e privo di elementi vincolanti.
I temi centrali della trentesima edizione
I. Adattamento, resilienza e natura
Il tema dominante. Il divario tra bisogni e finanziamenti cresce, mentre gli impatti fisici si intensificano. Il Global Mutirão ha formalizzato l’obiettivo di triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035, pur senza definire una ripartizione chiara degli impegni tra contributori. Contestualmente, è stata lanciata la NAP Implementation Alliance, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione dei Piani Nazionali di Adattamento.
Il contesto amazzonico ha riportato al centro la natura come elemento strutturale della stabilità climatica e come asset economico essenziale. Le iniziative discusse includono nuovi meccanismi di protezione forestale, programmi di ripristino dei terreni e modelli integrati che coniugano agricoltura, protezione sociale e resilienza rurale.
II. Sicurezza idrica e resilienza sistemica
L’acqua è emersa come tema trasversale della COP, non solo come priorità di adattamento ma anche come rischio sistemico per economie e catene di fornitura. Il negoziato ha posto l’accento su infrastrutture idriche resilienti, governance dei bacini e integrazione del rischio idrico nelle valutazioni finanziarie. A ciò si è aggiunta la Blue NDC Challenge, con il relativo Blue Package di 27 azioni dedicato a ecosistemi marini e comunità costiere, mirato a mobilitare 170 miliardi USD entro il 2030. L’adattamento oceanico è stato riconosciuto come leva per sicurezza alimentare, biodiversità e riduzione delle emissioni, con potenziali contributi fino al 35% entro il 2050.
III. Industria, energia e digitalizzazione
Industria, energia e digitalizzazione risultano sempre più intrecciate nella traiettoria della transizione delineata a Belém. La digitalizzazione è stata presentata come abilitatore chiave per adattamento, early warning e modellizzazione climatica, mentre cresce la preoccupazione per l’impronta emissiva del settore ICT e per il volume crescente di e-waste. In parallelo, la modernizzazione delle infrastrutture energetiche è emersa come priorità strutturale: le utilities hanno annunciato circa 150 miliardi USD l’anno destinati a reti e sistemi di storage, verso una pipeline da 1 trilione USD entro il 2030, sostenuta dal lancio del Global Grids and Storage Coordination Council e dei Climate Finance Principles for Grids. Sul fronte industriale, la Belém Declaration ha consolidato l’agenda della green industrialisation, mentre il Belem4X pledge sui combustibili sostenibili — ora sottoscritto da 23 Paesi — mira a quadruplicarne l’uso nei settori hard-to-abate entro il 2035.
Cosa significa per gli investitori
A valle degli avanzamenti emersi e delle aree in cui il negoziato ha proceduto con minore decisione, gli esiti di COP30 hanno delineato implicazioni concrete per il quadro regolatorio, le strategie di portafoglio e i processi di gestione del rischio.
I. Implementazione dal basso
Gli impegni assunti a livello nazionale si stanno traducendo in un ampliamento della regolazione locale: aggiornamento dei codici edilizi, nuovi criteri di procurement, standard per raffrescamento e resilienza termica, requisiti sui materiali, oltre a norme rafforzate per la gestione idrica e dei rifiuti. Tali interventi influenzeranno in maniera diretta la configurazione delle future pipeline progettuali e l’allocazione del capitale nei settori più esposti alla transizione.
II. Nuove opportunità (e nuovi rischi)
Opportunità:
- infrastrutture urbane resilienti (edifici, housing, trasporti, raffrescamento),
- soluzioni digitali e AI per adattamento e risk analytics,
- tecnologie idriche e sanitarie resilienti,
- agritech e soluzioni per la resilienza dei piccoli produttori,
- sistemi circular waste e riduzione del metano,
- grid, storage ed espansione delle reti elettriche.
Rischi:
- pressioni regolatorie crescenti sugli asset digitali ad alta intensità energetica,
- aspettative più stringenti su cooling, metano e rifiuti,
- crescente scrutinio sul consumo idrico, uso del suolo e catene di fornitura sensibili,
III. Una nuova narrativa fiduciaria
Nel corso della COP si è intensificato il dialogo tra policymaker, asset owner e corporate leader, anche grazie alla piattaforma di confronto dell’Asset Owner Summit, convergendo su tre assi principali:
- una mappatura condivisa delle soluzioni di transizione, comprendenti mitigazione, adattamento e natura,
- l’individuazione di geografie prioritarie, con particolare attenzione ai mercati emergenti,
- una definizione congiunta e aggiornata del dovere fiduciario in un contesto caratterizzato da rischi climatici crescenti.
Nel corso della COP, si e’ inoltre intensificato il dialogo tra asset owner e corporate leader grazie alla piattofrma di dialogo High-level dell’Asset Owner Summit, convergendo su tre direttrici principali:
- una mappatura condivisa delle soluzioni di transizione, comprendenti mitigazione, adattamento e natura;
- l’individuazione di geografie prioritarie, con particolare attenzione ai mercati emergenti;
- una definizione aggiornata del dovere fiduciario in un contesto caratterizzato da rischi climatici crescenti.
Il documento finale presentato ai Ministri delle Finanze ha evidenziato la necessità di rafforzare gli strumenti a supporto della finanza di transizione, pur senza introdurre elementi prescrittivi.
L’esito complessivo ha confermato che la credibilità dei percorsi di transizione tende a configurarsi come componente strutturale e non più accessoria della responsabilità fiduciaria.
Conclusione
COP30 non avrebbe potuto, da sola, risolvere le tensioni politiche globali né colmare il divario verso gli 1,5°C. Ha tuttavia auspicabilmente posto le basi per una nuova fase della governance climatica, in cui l’attenzione si sposta dalla dichiarazione all’attuazione: meno narrativa, più implementazione; meno promessa, più delivery.
Per gli investitori, il messaggio è duplice:
- il rischio climatico sta rapidamente diventando rischio finanziario;
- le opportunità di investimento in infrastrutture, adattamento e soluzioni digitali stanno accelerando.
Belém potrebbe così configurarsi non soltanto come una conferenza di transizione, ma come il momento in cui la finanza internazionale ha iniziato a misurarsi in modo più concreto e sistematico con la sfida dell’attuazione.